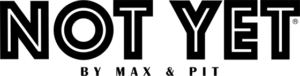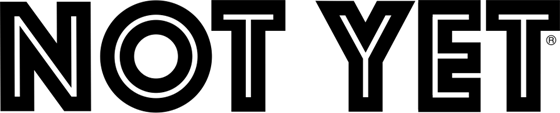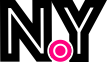Intervista ad Anika Krbetschek
Seduta Artistica no. 01
‘Seduta artistica’ è un progetto curato da Silvia Russo, focalizzato sulla libera espressione emozionale e creativa di artisti impegnati nello sviluppo di sé stessi in una realtà contemporanea con la quale scontrarsi.
Il rapporto curatrice-artista è basato su un ascolto diretto. Nell’intervista la curatrice interviene il meno possibile, lasciando che il flusso di pensiero dell’intervistato scorra libero senza essere contaminato.
Il progetto mira a dare voce a quella parte dell’artista meno conosciuta, più intima, e più – inconsciamente o volutamente – nascosta agli occhi degli altri.
Into the artist’s mind
Anika Krbetschek è una brillante artista interdisciplinare, curatrice e autrice con sede a Berlino. È energica, attiva, in continua evoluzione e sperimentazione. La nostra lunga conversazione si concentra su una serie di temi cruciali, con particolare attenzione alla destigmatizzazione dei cosiddetti “disturbi mentali” e il ruolo dell’arte contemporanea nell’affrontare questioni di identità, percezione e inclusione sociale.
Anika, con grande apertura e sincerità, condivide molte tracce del suo passato, tra cui il suo trascorso come paziente e artista all’interno dell’ambiente psichiatrico. Attraverso queste esperienze personali, ha maturato una prospettiva unica sulle sfide che le persone affrontano quando si trovano ai margini della società, tanto da comprendere che il suo posto nel mondo esiste attraverso l’impegno sociale e l’espressione artistica. Il lavoro di Anika è un’indagine in profondità di fenomeni psichici interni e del loro impatto sulla sensazione e percezione dell’individuo. Nei suoi progetti, cerca di dare visibilità e promuovere la destigmatizzazione dei disturbi mentali e delle divergenze neurofisiologiche considerate al di fuori della presunta normalità.
Anika non solo mette in discussione l’etichetta di “malattia” per le esperienze psichiche interiori, ma trascende anche il concetto di confini tra ciò che è considerato normale e non, trattandole piuttosto come un continuum di esperienze umane. I suoi lavori artistici fungono da cornici riflessive per il pubblico, offrendo uno spazio in cui le persone possono comprendere e connettersi con manifestazioni psicologiche all’interno del loro spettro personale di esperienza.

Nel corso della conversazione, esploriamo l’influenza del suo passato e dei trascorsi difficili sulla sua arte, e il suo impegno di dar voce alle persone emarginate nella società contemporanea. Affrontiamo inoltre il dibattito del mondo dell’arte contemporanea e come questo possa contribuire a promuovere una maggiore consapevolezza e accettazione delle diversità.
Ciao Anika! Innanzitutto, come ti piacerebbe presentarti?
Prima di iniziare a parlare del mio lavoro e del mio approccio, credo che il punto di partenza per me e per tutte le mie azioni sia che sono nata in primavera, il che significa che credo negli inizi, nel cuore di una prima luce, nella crescita e nella fioritura. Credo nel cambiamento e per cambiamento intendo dire che credo nella passione, nella collaborazione, nella partecipazione. Provengo da un ambiente di profonda sensibilità per la percezione emotiva, la sensazione e l’immaginazione, così come per il dolore, l’abuso e la diffidenza. Riunire tutto questo potrebbe essere un mio obiettivo di vita personale. Usare tutto ciò per far parte di un mondo più giusto e in guarigione è sicuramente il mio obiettivo lavorativo.
Qual è la principale forza trainante dietro la tua ricerca e cosa ti ha motivato a intraprendere una carriera artistica?
In realtà intraprenderla non è stata davvero una scelta. Ho iniziato a fare arte quando non potevo fare nient’altro per sopravvivere. Sembra drammatico, e forse lo è stato. Ho iniziato a fare arte intensivamente quando ero una paziente suicida, in psichiatria. E da allora è tutto ciò che so fare. È il mio modo di trasformare i miei sentimenti, di assorbirli in modo non dannoso ma bello e liberatorio.
Gli anni di arte-terapia hanno poi plasmato tutto il mio approccio artistico. Quindi, per me, teoricamente, trovo che fare arte sia il modo più efficace per perseguire i miei obiettivi terapeutici e attivisti. E devo anche dire che è ancora l’unica cosa che posso fare senza “ammalarmi”.

Ci troviamo di fronte alla situazione in cui la tua pratica artistica ti ha salvato, giusto?
Sì. Sono arrivata all’arte attraverso l’arte-terapia. La mia prima sessione é stata in ospedale e ci sono voluti meno di venti minuti prima che chiedessi alla terapeuta: “Ok, cosa devo fare per diventare un’arte-terapeuta?”. È stato così chiaro per me da quel momento in poi di voler intraprendere quella strada. Sono passata da paziente a lavorare nell’Atelier della mia terapeuta. Lungo il mio percorso, ho creato molti formati e progetti artistici diversi, che mi hanno portata alla consapevolezza di poter sviluppare altri modi di lavorare terapeuticamente con l’arte come artista, diversamente da quanto avrei potuto fare come arte-terapeuta. Ed è così che sono arrivata fin qui. Immagino che l’approccio che ho imparato nell’arte-terapia plasmi ancora il mio lavoro ed sia diverso da quello che si apprende nelle arti accademiche. Sono ancora molto orientata al processo, in modo aggressivo.
Questo è molto toccante. Qual è stata la transizione tra fare arte per te stessa per sopravvivere e farlo per un pubblico?
C’è stato un momento in cui ho capito che condividere le mie storie e i miei sentimenti significava non solo lavorare a livello personale, ma anche rendere visibile il vissuto degli altri. Le mie esperienze sono radicate in questioni strutturali all’interno di una società patriarcale egemonica. Non sono solo personali: c’è un contesto sociale più ampio dietro d’esse. Rendere visibili queste questioni non è solo una forma di auto-terapia, serve a uno scopo all’interno di un contesto attivista e si allinea con il lavoro legato alla giustizia. Creare queste diverse prospettive implica sempre la creazione di narrative, che mettono in discussione le strutture sociali prevalenti. Questo, credo, fa parte del cambiamento. Il processo psicologico e l’arte condividono un profondo legame per me e l’arte è essenziale non solo per elaborare queste esperienze a livello personale ma anche per sfidare le strutture consolidate, sia nel sistema sociale che nel mondo dell’arte, contribuendo a un cambiamento inclusivo.

Il tuo progetto più recente, ‘f44(0)’, esplora la perdita di memoria in vari contesti, come l’infanzia, la casualità e l’amnesia dissociativa dovuta a stress traumatici. È stato esposto sia al 48h Neukölln Art Festival che alla Kulturfabrik Moabit a Berlino nell’estate 2023 come parte della mostra ‘Molding into the Fabric’. A tal proposito volevo chiederti, perché questo argomento è molto importante per te e come è collegato alla destigmatizzazione delle malattie mentali?
È collegato perché tutto ciò che faccio è guidato da questo approccio di creare contesti in cui le persone possono sperimentare una sorta di manifestazione psicopatologica di ciò che passiamo tutti. Spero che all’interno di questo contesto possano relazionarsi al loro spettro di esperienze personali e capire che va oltre i confini tra malattia e normalità, tra ciò che è considerato normale e ciò che non lo è. Si tratta di riconoscere che è un continuum, forse persino parte di sé stessi.
E credo che questo sia cruciale per la destigmatizzazione. Possiamo discutere a lungo della salute mentale e delle sue specificità, ma se non raggiungiamo quel punto, è inutile. L’obiettivo dell’installazione recente ‘f44(0)’, che è un progetto realizzato in collaborazione con Marco Borowski – insieme ad artisti con e senza esperienze di trauma grave – era quello di illustrare due tipi di perdita di memoria o due categorie di ricordi che tendono a sbiadire. Un tipo include ricordi che sono forse troppo casuali per essere ricordati consapevolmente. In questo caso, abbiamo lavorato con l’archivio personale di video di Marco su ricordi che si sono verificati casualmente durante tutta la sua vita. L’altro tipo di memoria, tradotta in video-arte, riguarda il ricordo che non è stato nemmeno inizialmente archiviato nel cervello perché era così intrusivo o dannoso che il cervello stesso doveva dissociarsene. Tuttavia, credo fermamente che niente si perda veramente in questo senso. Rimane nella mente inconscia, ed è per questo che continua a influenzarci. In questo progetto, quindi, ho affrontato il tema dei ricordi in modo molto tecnico, pensando ai meccanismi del cervello nel trattare i ricordi in modo diverso, a seconda dell’effetto che hanno sulle nostre emozioni e sul nostro essere interiore. In generale, sono artisticamente molto interessata al concetto di frammentazione e dissoluzione, e questi sono anche concetti molto interessanti dal punto di vista artistico, ma possono avere un significato diverso quando li mettiamo nel contesto della psiche, in quanto sono principi fondamentali dei processi dissociativi, e, in particolare, dell’amnesia dissociativa, che causa la perdita di memoria, su cui abbiamo lavorato nell’installazione di cui stiamo parlando. Posso usare questi concetti artistici, l’astrazione, per rendere comprensibili i processi e i meccanismi dietro queste manifestazioni patologiche.

Dato che hai avuto esperienze in ospedali psichiatrici, sia come paziente che lavorandoci come arte-terapeuta, volevo chiederti: cosa succede davvero all’interno di un ospedale psichiatrico e com’è stato per te?
Riguardo alle mie esperienze con la psichiatria, è piuttosto interessante perché ho conosciuto entrambi i lati, sia come paziente sia lavorando lì. Per quanto mi riguarda personalmente, avevo semplicemente bisogno di posto al di fuori della società e del mio ambiente in primo luogo. Anche se criticherei la pratica di separare i “malati mentali” dalla società, a volte può essergli benefica, immagino. In alcuni casi la società può essere più pericolosa per i pazienti, piuttosto che l’allontanamento da essa.
Nelle sezioni per bambini non si può decidere nulla da soli: regole rigide, divieto di uscire e di ricevere visite o chiamate senza il permesso dei genitori, niente telefono.
Certo, io ai tempi avevo meno di diciotto anni, ma per me questa mancanza di autodeterminazione ha reso tutto più difficile. Ricordo quanto fossero alte le pareti, come si percepissero le loro pietre. Puoi ancora vedere i nomi dei miei compagni di stanza incisi nei mattoni rossi e l’anno in cui sono finalmente andati via da lì. Per le prime due settimane non mi è stato nemmeno permesso di lasciare i 50 metri del pavimento della sezione in cui mi trovavo io, ricevere visite dagli amici, o scendere al piano di sotto.
Questo era per la mia protezione, in realtà, ma comunque non potevo vedere il cielo, i miei alberi, sentire il terreno reale sotto di me. Quindi ho dovuto trovare il mio modo di evadere. Ho vissuto anche dei brutti episodi con gli psicoterapeuti e ricevuto affermazioni pericolose e sciocche. Ad esempio, un medico mi disse una volta: “Sei il tipo di donna che sarà sempre circondata da uomini violenti“. Mi hanno anche detto che quando mi avrebbero congedata, avrei certamente avuto una ricaduta e sarebbe stata colpa mia, cose del genere insomma. Puoi immaginare quanto devastante sia stato.
Quando in seguito ho lavorato in prima persona in una stazione psichiatrica, non dimenticherò mai le stanze di isolamento, luoghi disumani. Quando i pazienti in cerca di aiuto vengono rinchiusi in una stanza senza niente, iniziano a graffiare le pareti – lo farei anch’io. Era inquietante. Capisco perché questi spazi esistano ma il fatto che qualcosa possa essere necessario non lo rende giusto. Trovo che sia straziante. A volte, penso ancora ad alcune di queste persone: cosa gli sarà successo? Saranno riuscite ad uscire dal circolo psichiatrico?
Ricordo questa ragazza che ho conosciuto in una stazione psichiatrica per bambini quando ero lì come paziente. Aveva undici anni all’epoca e anche io ero molto giovane. In seguito, quando ho iniziato a lavorare in un ospedale psichiatrico diverso, lei é diventata paziente nella mia stazione. In quei nove anni della sua giovane vita, non era mai uscita dalle istituzioni psichiatriche. È stato uno shock. Mi ha fatto capire le difficoltà del reinserimento nella società: come avrebbe fatto questa ragazza dopo quasi tutta la sua vita in un centro, dove quella era diventata la sua unica realtà? Cosa ci sarebbe stato per lei all’esterno? Ho imparato che molte persone rinchiuse lì sono completamente fuori dalla società, ma ce ne sono altre che hanno una vita considerata normale, nonostante sia comunque difficile per loro vivere, in un certo senso. La linea tra la normalità e l’anormalità è talvolta più sfumata di quanto si pensi.

É davvero intrigante come la tua espressione creativa spazi dall’installazione alle arti visive, fino alla performance. Come vivi le esibizioni live e cosa spinge il tuo istinto a impegnarti in esse?
Anche qui, si può fare riferimento alla terapia. Capire la psiche significa per me capire me stessa. Ma certi argomenti o specialmente certi ricordi non possono essere affrontati direttamente, in modo tecnico o analitico. Specialmente nel lavoro sul trauma, sono necessarie tecniche più astratte. E a volte devi solo sentire e trasformare, gridare, correre, gettarti in mare. Quindi, quando elaboro esperienze o argomenti legati a esperienze traumatiche, uso la performance per questo, quando ho davvero bisogno dell’esistenza di me stessa, del mio corpo e del mio essere. Inoltre, a volte penso che ci voglia molto coraggio. Specialmente perché non direi che sono una performer di carattere, o perché mi piace particolarmente questo modo di espressione. Non faccio performance fino a quando non ne sento il bisogno. Ma quando accade ho un irresistibile impulso a impegnarmi in essa. Ecco perché non penso alla vergogna, alla vulnerabilità, alla paura del palco, a mettermi in mostra, o persino alla re-traumatizzazione o al crollo sul palco, prima di eseguire. Devo farlo e basta.
Le performance emotive possono essere incredibilmente potenti sia per il pubblico ma soprattutto per gli esecutori. Come ti senti prima, durante e dopo?
Ti spiegherò con un esempio. Una volta ho riletto i miei vecchi diari, che riguardavano esperienze di violenza. Mi è sembrato di dover affrontare di nuovo questa situazione, ritornando sempre alla riconciliazione e mi sono sentita abbastanza sola e ferita. E poi mi sono chiesta: cosa succederebbe se mettessi tutto questo sul palco? Cosa succederebbe se lo incorniciassi in un atto artistico? Potrei anche ottenere un certo tipo di controllo su una situazione retraumatizzazione come questa? E allora l’ho fatto. Volevo davvero portare la terapia sul palco. Quindi ho fatto la performance ‘Saying No. A process in six Acts’. E in realtà si è rivelato un atto molto potente. Voglio dire, ho avuto una reazione molto intensa dal mio corpo e dal mio essere, non è stato facile, ma in realtà non ho riportato una retraumatizzazione. La cosa più interessante per me è stata che non ero solo io a vivere questo momento terapeutico sul palco, ma il pubblico in seguito è venuto da me, ci sono state molte persone con una reazione emotiva intensa perché avevo toccato il tema dell’abuso. È stato un po’ strano perché sono scesa dal palco e mi sentivo così libera. Mi sentivo forte, avevo avuto il mio momento di trasformazione; questo tipo di spettacolo sembra un esorcismo, in un certo senso.
Attraverso la reazione del pubblico, ho capito: se la mia voce e le mie esperienze rappresentano un intero gruppo di persone colpite da abusi, stupri e violenza, allora deve esserci un problema strutturale.