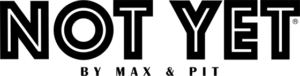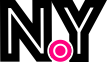Creative Journeys
Nell’era della globalizzazione e dell’iperconessione, continua a non esaurirsi il bisogno insito nell’essere umano di esplorare, conoscere e andare oltre il proprio immaginario quotidiano. La digitalizzazione permette oggi di raggiungere virtualmente qualsiasi meta ed essere sempre informati su ciò che accade anche nei luoghi più remoti del Pianeta. Con gli strumenti attualmente disponibili possiamo arrivare ovunque, ma l’istinto accompagnato dal bisogno di rivedere le proprie priorità continua ad attirarci verso una necessità di conoscenza diretta del mondo, che solo il viaggio può appagare.

Le nuove generazioni stanno vivendo un brusco risveglio dai valori tradizionali dell’Occidente, dai fondamenti di una felicità illusoria e talvolta superficiale che non soddisfa più le necessità del singolo. Nasce così un desiderio di apprendere attraverso nuove prospettive e aprire la propria mente verso qualcosa di sconosciuto e alternativo, che possa infine diventare rivelazione e auto-conoscimento. Il confronto con l’altro dà vita a uno scambio che spinge a mettersi in gioco, rinnovare quella voglia di prendere e partire per acquisire piena coscienza di sé e delineare nuovi obiettivi.

Viaggiare, infatti, è un atto che si compie anche per il bisogno di trascendere quello che sta intorno a noi. Così, da un lato il viaggio permette di uscire e distaccarsi momentaneamente da ciò che si conosce per osservare e interiorizzare qualcosa di nuovo, di cui si sente la necessità ma che non si trova; dall’altro, diventa uno strumento per approfondire, per non stare in superficie e sperimentare con la propria pelle qualcosa di diverso, talvolta un diverso “esterno” che troviamo nelle differenze di altre culture e usi, o ancora, un diverso che ti permetta di andare al di là di un’emozione e di percepirla, esplorarla e leggerla attraverso occhi nuovi. Affrontare il diverso, in questo senso, può disvelare anche il buono di un passato che ci ha preceduto, ci appartiene e vogliamo riscoprire per far emergere punti comuni che ci rendono fondamentalmente parte di una stessa umanità. Da qui nasce un senso di collettività che spinge prima a non voler più ignorare i problemi che sembrano così distanti se osservati dietro allo schermo di un dispositivo e poi ad affrontare attivamente la realtà per costruire un’autentica empatia verso ciò che appare distante ma, in realtà, ci riguarda in quanto umani.
Il viaggio è una dimensione che coinvolge i sensi e la mente e dona nuovi strumenti per condurre la propria esistenza.

Esso rimane tuttavia un concetto sfaccettato, che può riguardare sicuramente un muoversi verso altre mete ma che implica sempre un movimento, un cambiamento, o una crescita anche nella dimensione più interiore. In senso più metaforico, il viaggio può essere vissuto come un percorso personale e riguardare la sfera introspettiva: diventa così una ricerca nel profondo, una scoperta di quel vero “io” che è capace di renderci ciò che siamo.
Così, l’emblema del viaggio diventa per Not Yet l’attrice di origini partenopee Giovanna Sannino, ritratta nella copertina di questo issue. Per lei l’importanza del viaggio tocca infatti le due sfere menzionate, quella di una dinamicità fisica e quella dell’interiorità. È proprio durante un soggiorno fuori porta che Giovanna abbraccia la sua trasformazione da ragazzina a donna e si rende cosciente dei propri desideri, ambizioni e delle sue più autentiche necessità, decidendo così di intraprendere la strada della recitazione.
Insieme a questa nuova consapevolezza l’attrice, intenta a superare le difficoltà di un vissuto travagliato, imbocca un percorso che la porti ad esplorare i suoi sentimenti e le sensazioni più recondite. Grata dei benefici apportati dal suo viaggio di ricerca introspettiva, Giovanna ha deciso oggi di allungare una mano verso altre persone volenterose di avventurarsi nella via dell’auto-conoscimento, pronte ad affidarsi a lei per iniziare insieme un viaggio emotivo e sensoriale.

Per ordinare una copia cartacea scrivici su Instagram oppure via mail a info@notyetmagazine.com e ricevila comodamente a casa. La spedizione è inclusa al costo di 22€ in Italia e a partire da 35€ per le spedizioni estere.
To purchase a hard copy DM us on Instagram or send us an email to info@notyetmagazine.com and receive it in the comfort of your home, wherever you are. We ship all over the world at the price of €22 (shipping included) throughout Italy, and from €35 for deliveries abroad.