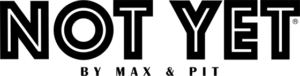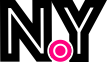Anti-intervista a Pier Danio Forni: dagli Husky Loops a Kari Faux
Si tratta del dubbio amletico che affligge un ingente numero di musicisti e produttori musicali italiani: partire o non partire?
La verità è che la maggior parte di loro decide di rimanere nel luogo in cui sono nati, forse per paura di un ignoto che, alla fine, tanto ignoto non è; oppure per il semplice motivo che in Italia mangiamo troppo bene per “prenderci su” e dire addio ad una digestione più che appropriata.
Tuttavia, non è il caso di Danio, frontman della band italo-britannica Husky Loops e collaboratore musicale di Willow Kayne, Kari Faux, Twst.

Dotato di enorme potenziale, Pier Danio Forni è il produttore di cui tutti avrebbero bisogno: è grintoso e affamato, aggettivi che possono benissimo essere utilizzati per i brani degli Husky Loops. Di origini bolognesi, cresce musicalmente con i classici cantautori italiani – Lucio Dalla, Luigi Tenco, Lucio Battisti – ma ben presto si schiera a favore delle produzioni estere, concentrando la sua formazione compositiva su Rap, Hip Hop – prevalentemente americani – e svariati sottogeneri del rock come garage, art, power duos. La musica che aveva intenzione di comporre, e che in seguito trovò la sua prima espressione nell’album ‘I Can’t Even Speak English’, riguardava l’unione dei generi pocanzi citati e pensò all’Inghilterra come terreno fertile dove coltivare collaborazioni che aprissero le porte a nuove possibilità melodiche1.
Deciso a fare il grande passo, si trasferisce a Londra all’età di vent’anni. Il luogo perfetto dove cementare l’amicizia con gli altri due componenti degli Husky Loops, Pietro Garrone (batteria) e Tommaso Medica (basso).
Insieme, si fanno portavoce di dissonanze underground ed inseriscono di tanto in tanto frammenti elettronici quasi completamente slegati dalla melodia originale, il che produce un “effetto sorpresa” non sempre facile da cogliere ma comunque ambizioso. Particolarmente inerente alla descrizione è il brano ‘Everytime I Run’, che si può ascoltare, oltre che su tutti gli streaming disponibili, anche sul videogioco FIFA19.
Dall’album ‘I Can’t Even Speak English’, si nota la chiara semplicità dei brani ‘Let Go For Nothing’ e ‘I Think You’re Wonderful’. La scelta di aggiungere un pianoforte come strumento portante dell’intera composizione funziona e la ricerca di un equilibrio è avvenuta con successo.


Com’è stato passare dalle strade bolognesi all’underground londinese?
Credevo di arrivare e trovarmi a dover imparare tutto da capo. Non è stato affatto così. Musicalmente, mi sentivo molto sicuro di me. I tratti italiani, insiti nelle mie composizioni, sono stati e sono tutt’ora una firma personale che mi discosta dalle classiche produzioni inglesi. Nascendo in Italia ma amando generi musicali che in Italia non vengono prodotti, credo di aver allenato l’immaginazione a tal punto da unire diverse realtà. Sono sempre stato attento a definire la mia ‘voce’.
La maggior parte delle tue produzioni, specialmente con gli Husky Loops, è ricca di riff2 memorabili inseriti in un contesto prettamente ripetitivo. Come se i The White Stripes collaborassero con produttori di musica rap. Ti ritrovi in quello che dico?
Assolutamente sì. È la nostra benzina: cercare continuamente la melodia più orecchiabile possibile e divertirci ad arrangiare3. Penso sia uno dei motivi cardine per cui faccio musica. Si tratta di una ricerca estenuante, di solito, ma che porta grandi benefici. Sono un grande fan della semplicità del messaggio. Riguardo il discorso della ‘ripetitività’, invece, non posso non citare J Dilla, che è stato per me e la band l’ispirazione per eccellenza. Molto di quello che scrivo proviene dal rap, come si può notare ascoltandoci.
Quando ascolto gli Husky Loops, percepisco aggressività ma anche consapevolezza di quello che state facendo. Dall’altra parte, ovviamente, se ascolto le canzoni che hai prodotto per Kari Faux, il ‘Pier Danio’ che mi sono abituato a sentire, scompare. Come hai imparato a dividere ‘ciò che Danio farebbe’ da ‘quello che gli altri ti chiedono di creare’?
Fare musica per sé stessi è ovviamente diverso dal crearla per qualcun altro. Collaborare con musicisti terzi è un po’ come fare terapia: ascolti i loro testi, le loro idee circa il sentimento del brano e infine, ti proponi come ‘essere umano’ che ha il compito di definire una serie di emozioni che non ti appartengono. È più difficile del previsto a volte ma se ciò che ne esce è di facile ascolto, significa che ho fatto bene il mio lavoro.
L’artisticità di un progetto, al giorno d’oggi, può essere raggiunta in tanti modi. Primo fra tutti, i social network. Tuttavia, il progetto band sembra poco interessato a creare un solido rapporto sociale nell’universo digitale. Me ne vuoi parlare?
Non ci è mai interessato creare contenuti. Anzi, sui social siamo quasi sempre ironici e forse un po’ troppo ‘realistici’ per il target richiesto. In quel mondo è richiesta una condivisione di contenuti edulcorati, l’estetica la fa da padrone ma noi non siamo fotomodelli. Non voglio svalutare il mondo dei social, che altri stanno usando in maniere invidiabili. Semplicemente, non ci interessa. Per l’uscita dell’album ‘I Can’t Even Speak English’, avevamo organizzato una serie di concerti a West London durante i quali il pubblico poteva imbrattare con i pennarelli diversi muri imbiancati, insieme ad altre idee. Volevamo creare un’interattività con i nostri fan che non avrebbe trovato il giusto sfogo sui social. Forse non ci abbiamo pensato abbastanza, ma rimaniamo fieri del risultato.

Si dice che l’innovazione nasce dalla mancanza di possibilità. Cosa ne pensi?
Penso sia l’unico e vero mantra di qualsiasi artista emergente: riuscire a fare quel che si vuole con il poco che si possiede. È sempre stata la miccia che ha acceso la maggior parte delle idee più innovative.
Vedasi, per fare un esempio pratico, il percorso compositivo di Jack White: durante il periodo ‘The White Stripes’ gli strumenti venivano registrati con metodi più ‘rozzi’ ma funzionali e di grandissimo impatto acustico. Non per niente Seven Nation Army è l’esempio più concreto di brano scarno di elementi seppur dotato di una potenza tale da fare invidia, ancora oggi, alla maggior parte delle produzioni. In generale, tutto il mondo indie-rock, britannico e americano, è nato con la consapevolezza che una chitarra elettrica, un fill4di batteria o un arpeggio5 di basso dimostrano il loro vero potenziale solo se si mantiene l’originalità del suono.
Le più belle sferzate creative che ho ottenuto, anche all’interno della realtà della band, sono quasi sempre passate attraverso la minor gamma di suoni che avevo a disposizione. Significa tirare fuori l’anima di un pezzo, ricordandosi che l’animo umano invece – astrattamente parlando – è di semplice fattura. Non c’è niente di più complicato, ma nulla eguaglia la soddisfazione provata quando si ascolta un pezzo che trova la genialità nella semplicità.
Concludo, chiedendoti: cosa significa essere o appartenere alla sfera underground?
Per me, essere underground significa ‘essere fedeli a sé stessi’ artisticamente parlando. Non deve essere una rincorsa all’ego, bensì un monito che ti ricorda da dove sei venuto. Provenire da realtà più piccole, dalle quali è più complicato slegarsi, ti aiuta a mantenere vivido in te il ricordo di chi sei stato, quindi di chi sei. È un po’ confuso, lo so, ma non è una domanda semplice. Per me ‘underground’ significa far girare per un po’ i propri dadi e giocare con le proprie regole, provare ostinatamente a definire il futuro con gli strumenti che ti sei allenato ad usare: nel mio caso, la musica.
Note per il lettore inconsapevole:
- Melodia: successione di suoni. Si tratta della linea di canto che l’orecchio percepisce al di sopra dell’intreccio delle voci.
- Riff: Il riff è una frase musicale che si ripete frequentemente all’interno di una composizione e che viene utilizzato di solito come accompagnamento.
- Arrangiare: con arrangiamento, in musica, si indica il lavoro di organizzazione strumentale e strutturale di una composizione.
- Fill: nella musica moderna l’indicazione fill (dall’inglese “riempimento) viene notata su uno spartito per indicare l’esecuzione di un passaggio libero, normalmente improvvisato.
- Arpeggio: l’arpeggio è un abbellimento che si applica a un accordo, in cui le note vengono eseguite in successione anziché simultaneamente.